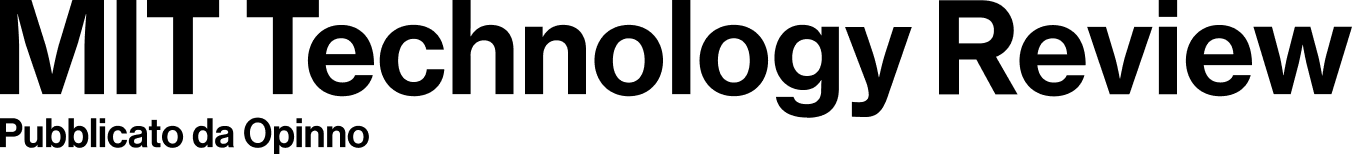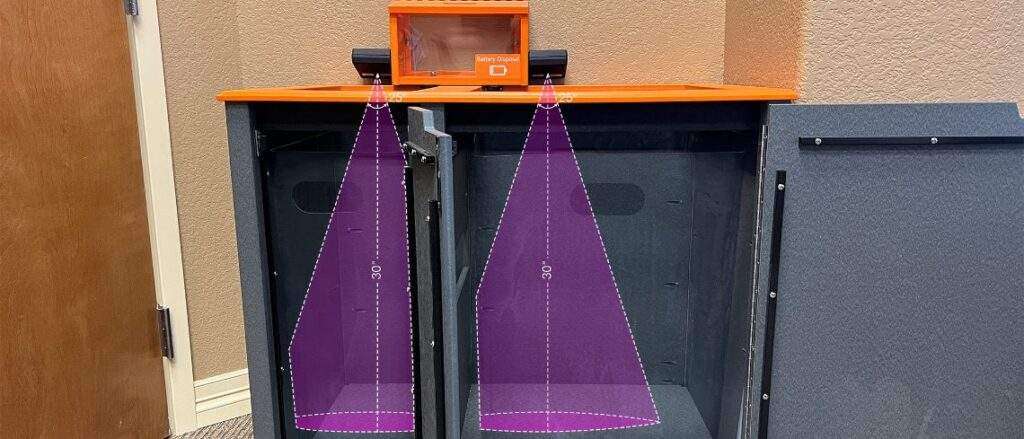Il progresso tecnologico non può avere come unico riferimento il guadagno immediato, ma dovrebbe sostenere un sistema che si ponga come problema principale da risolvere quello della fame nel mondo.
di Fabio Parasecoli
Non dimenticheremo facilmente quanto ci siamo preoccupati per il cibo nei primi giorni della pandemia: scaffali vuoti, prodotti scarsi e accaparramento diffuso erano una realtà allarmante in tutto il mondo. Pur essendo rassicurati sul fatto che le interruzioni erano “temporanee”, gli americani hanno anche sentito notizie preoccupanti su agricoltori che aravano i raccolti nei loro campi, produttori di latte che versavano il latte nelle fogne, impianti di confezionamento della carne che chiudevano. Nel frattempo, le file nelle mense e nei banchi alimentari erano aumentate.
A quanto pare, questi fallimenti derivano da caratteristiche integrate del nostro sistema alimentare. Era più economico distruggere i raccolti che raccoglierli e lavorarli in quanto gli acquirenti all’ingrosso come scuole e aziende di ristorazione avevano sospeso gli acquisti. I caseifici standardizzati sui grandi volumi non erano attrezzati per adattare le loro macchine all’imballaggio in contenitori a dimensioni adatte al consumatore. Gli impianti di confezionamento della carne avevano aumentato i ritmi di lavoro per soddisfare la domanda e l’affollamento sulle linee di lavorazione ha provocato una serie di contagi che hanno portato alla chiusura.
Lo shock della prima ondata del virus ha rivelato il funzionamento interno del nostro sistema interconnesso di produzione e consegna del cibo, e i suoi punti deboli. Questo sistema è, ovviamente, il risultato di decenni di progressi tecnologici, dalle reti di spedizione e di refrigerazione in tutto il mondo ai mercati delle materie prime che funzionano su Internet ad alta velocità e massiccia infrastruttura di cloud computing. Potrebbero ancora esserci altre spiacevoli sorprese in serbo per milioni di persone in tutto il mondo mentre la pandemia continua a correre. Per queste ragioni è importante cercare di capire come siamo arrivati a questo punto e come cambiare le cose in meglio.
Il costo della crescita
In poche parole, il moderno sistema alimentare è un prodotto del libero mercato capitalistico. Le decisioni su dove investire nella ricerca tecnologica e in che settori promuovere l’innovazione sono state guidate dalla spinta a una sempre maggiore efficienza, produttività e profitto. Il risultato è stato una costante tendenza a una maggiore abbondanza. Si prenda, per esempio la produzione di grano: grazie alle ferrovie, all’introduzione di attrezzature migliori e all’adozione di varietà a resa più elevata, la produzione negli Stati Uniti è triplicata tra gli anni 1870 dell’Ottocento e gli anni 1920. Allo stesso modo, la produzione di riso in Indonesia è triplicata in 30 anni dopo che i metodi meccanizzati e ad alta redditività della Rivoluzione Green sono stati adottati all’inizio degli anni 1970.
Ma come tutti sappiamo, la sovrapproduzione negli Stati Uniti all’inizio del XX secolo ha portato a una diffusa erosione del suolo e alla Dust Bowl, la tempeste di sabbia che ha colpito gli Stati Uniti centrali e il Canada tra il 1931 e il 1939. La crescita costante di rese più elevate è stata ottenuta utilizzando grandi quantità di fertilizzanti e pesticidi, nonché scartando varietà di colture locali ritenute non adatte. I terreni agricoli si sono concentrati nelle mani di pochi grandi protagonisti: gli Stati Uniti avevano circa un terzo delle fattorie nel 2000 rispetto al 1900, e in media erano tre volte più grandi.
Nello stesso periodo, la proporzione della forza lavoro statunitense impiegata in agricoltura è passata da poco più del 40 per cento a circa il 2 per cento. Le catene di fornitura hanno continuato a essere ottimizzate in termini di velocità, riduzione dei costi e aumento del ritorno sugli investimenti. I consumatori hanno in gran parte accettato volentieri la maggiore convenienza derivante da queste politiche, ma c’è stata anche qualche reazione negativa.
I prodotti distribuiti a livello globale possono sembrare senz’anima, lontani dalla tradizione culinaria locale e dai contesti culturali: mirtilli in pieno inverno o la stessa marca di patatine in angoli remoti del pianeta. Come reazione, i più ricchi ora cercano “autenticità” e si rivolgono al cibo come simbolo della propria identità. Sospetti o critiche dirette alla tecnologia sono emersi all’interno del cosiddetto food movement, insieme a un frequente e acritico abbraccio di fantasie pastorali che a volte riflettono le preferenze dei consumatori più ricchi (e quasi sempre bianchi).
Tali atteggiamenti non riescono a riconoscere l’ovvio: la disponibilità, l’accessibilità e i costi contenuti del cibo industriale hanno rappresentato una forza importante nel ridurre l’insicurezza alimentare in tutto il mondo. Il numero di persone che soffrono di denutrizione è sceso da circa 1 miliardo nel 1990 a 780 milioni nel 2014 (anche se la fame è di nuovo in aumento), mentre la popolazione mondiale è aumentata di 2 miliardi nello stesso periodo.
Criticare la produzione di massa di cibo di per sé è fuorviante. Le imperfezioni sono molte, particolarmente per quel che riguarda l’eccesso di calorie e la scarsità di sostanze nutrienti, ma non è la rovina del nostro pianeta e del nostro benessere. Sicuramente no, se si faranno scelte che tengano conto di fattori diversi dal profitto.
Il valore dei valori
La chiusura degli impianti di macellazione e confezionamento della carne in risposta al covid-19 ha causato problemi a monte, costringendo gli agricoltori a uccidere e smaltire il bestiame troppo costoso da nutrire senza la certezza delle vendite. Questo è ciò che accade quando un sistema ottimizzato per efficienza, produttività e profitto si scontra con uno shock.
La tecnologia, tuttavia, non è intrinsecamente contraria alla sostenibilità e alla resilienza. In effetti, molti dei problemi comunemente attribuiti alla tecnologia nel sistema alimentare derivano dal quadro giuridico e finanziario in cui si sviluppa. La proprietà intellettuale è una questione centrale in quanto chi ha un brevetto lo ha utilizzato quasi esclusivamente per massimizzare i profitti e non per migliorare la sicurezza e la qualità degli alimenti.
La modificazione genetica rappresenta un ottimo esempio. Per la maggior parte, le sue tecniche sono state applicate a colture commerciali come grano, soia e mais, coltivate in enormi quantità e scambiate a livello internazionale. L’obiettivo è univoco: aumentare i raccolti, anche quando ciò richiede un uso più pesante di pesticidi e fertilizzanti, che sono spesso brevettati dalle stesse aziende che possiedono i brevetti per gli OGM.
Lo stesso investimento in modificazione genetica e agrotecnologia manca, tuttavia, per molte colture che fungono da base per milioni di piccoli agricoltori in tutto il mondo, dal taro nelle isole del Pacifico, nell’Asia meridionale e nell’Africa occidentale alla manioca in America Latina e in vaste aree dell’Africa. Se applicate a quelle colture nel perseguimento della sicurezza alimentare, le tecnologie genetiche potrebbero essere utilizzate per creare un’agricoltura locale più forte e più resiliente e un sistema alimentare più sano, ma non lo sono, perché ciò non genererebbe profitti abbastanza grandi da coinvolgere il settore privato delle biotecnologie.
A peggiorare le cose, molti paesi a basso reddito sono stati anche storicamente costretti ad accettare accordi commerciali e finanziari dal FMI, dalla Banca mondiale e dall’Organizzazione mondiale del commercio che aprono i loro mercati ai raccolti commerciali fortemente globalizzati.
Eppure, la maggior parte dei dibattiti sugli OGM si concentra sul loro presunto pericolo per la salute umana – per il quale ci sono poche prove scientifiche – invece che sul modo in cui danneggiano i piccoli agricoltori e le comunità circostanti. In breve, concentrandoci su problemi tecnologici spuri, stiamo ignorando quelli legali e sociali molto reali.
La via da seguire, quindi, è fare scelte che allineano i progressi tecnologici con le cause della sostenibilità, della resilienza agli shock e del benessere delle persone, e non esclusivamente con i profitti delle grandi aziende. Ci sono già molti esempi. La Navdanya Community Seed Banks, avviata in India dall’attivista Vandana Shiva, incoraggia chi lavora (principalmente donne) a diventare custodi dei semi, mettendo a disposizione degli agricoltori varietà a rischio di estinzione per coltivarle e incrociarle. Queste tecnologie di conservazione a basso costo aiutano a mantenere l’agrobiodiversità, identificando, selezionando e proteggendo il materiale genetico in via di scomparsa.
La questione della proprietà e del controllo tocca anche altri aspetti dell’intreccio tra tecnologia e sistema alimentare. C’è una lunga lista di apparecchiature che promettono di rivoluzionare il duro lavoro di coltivazione della terra. Gli agricoltori possono collegare i loro campi con sensori abilitati a Internet, monitorare i raccolti e il bestiame con droni agricoli o gestire l’inventario utilizzando una blockchain. Possono usare i loro telefoni cellulari per accedere ai dati sul tempo, sui parassiti e sui costi di produzione e dei raccolti.
Ma gli incentivi delle aziende che stanno dietro a tali innovazioni sono di vendere quante più app e dispositivi e flussi di dati possibile, non di assicurare il cibo a tutti. Se le aziende cambiano il loro modello di business, interrompono un prodotto o servizio, o semplicemente abbandonano, gli agricoltori sono alla loro mercé. La produzione e la sicurezza alimentare sono così connesse al cibo in quanto diritto umano – e così cruciale per la sopravvivenza di intere comunità – che la tecnologia e i diritti di proprietà intellettuale in questo settore dovrebbero funzionare secondo principi e priorità diversi da quelli seguiti altrove nel settore tecnologico.
Per esempio, si potrebbe richiedere alle aziende tecnologiche di rendere i loro brevetti di pubblico dominio dopo alcuni anni o di condividere i profitti delle royalties in cambio dell’accesso a nuovi mercati. Oppure suggerire alle aziende agricole che sviluppano nuove colture basate su materiale genetico da piante in comunità specifiche di addestrare i membri di quelle stesse comunità a diventare biologi e tecnici, condividendo anche i diritti con loro.
Esiste già un accordo internazionale che impone l’accesso alle risorse genetiche e l’equa condivisione dei benefici: 128 paesi hanno ratificato il protocollo di Nagoya mediato dalle Nazioni Unite da quando è stato adottato nel 2010 (sebbene Stati Uniti, Russia, Brasile e Australia non l’abbiano ancora fatto). Le suddette politiche di libero scambio al centro degli accordi OMC, che da decenni ostacolano i paesi a basso reddito, potrebbero essere riviste in modo che quei paesi possano gestire le loro scorte alimentari e le loro politiche di import-export con un occhio di riguardo agli investimenti in ricerca locale e tecnologia.
Sono scelte profondamente politiche. Non dovrebbero essere lasciati a meccanismi economici apparentemente autoregolati o alla ricerca di efficienza e produttività sempre maggiori. Tali priorità devono essere bilanciate con altre per garantire il massimo beneficio umano possibile. Per raggiungere questo risultato, è necessaria la partecipazione attiva di governi, attivisti, organizzazioni internazionali, istituti di ricerca, organizzazioni non governative e rappresentanti delle comunità locali… il tipo di coalizione autentica e democratica che accontenterebbe anche l’attivista più esigente del food movement.
Immagine: Pablo Delcan