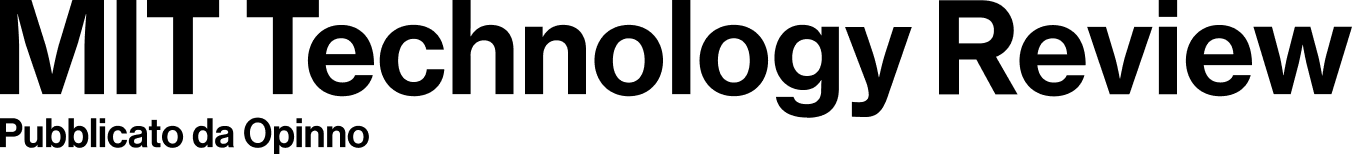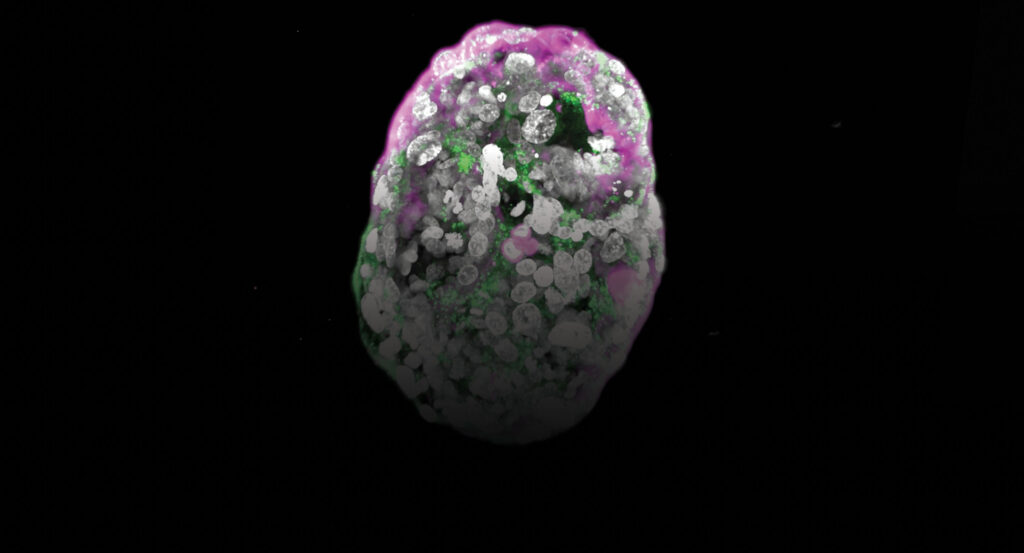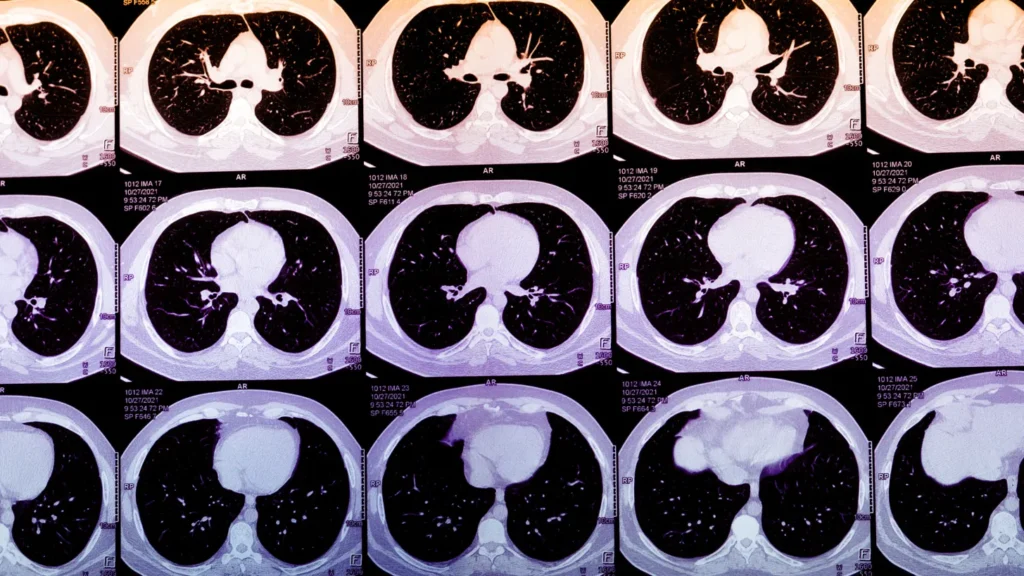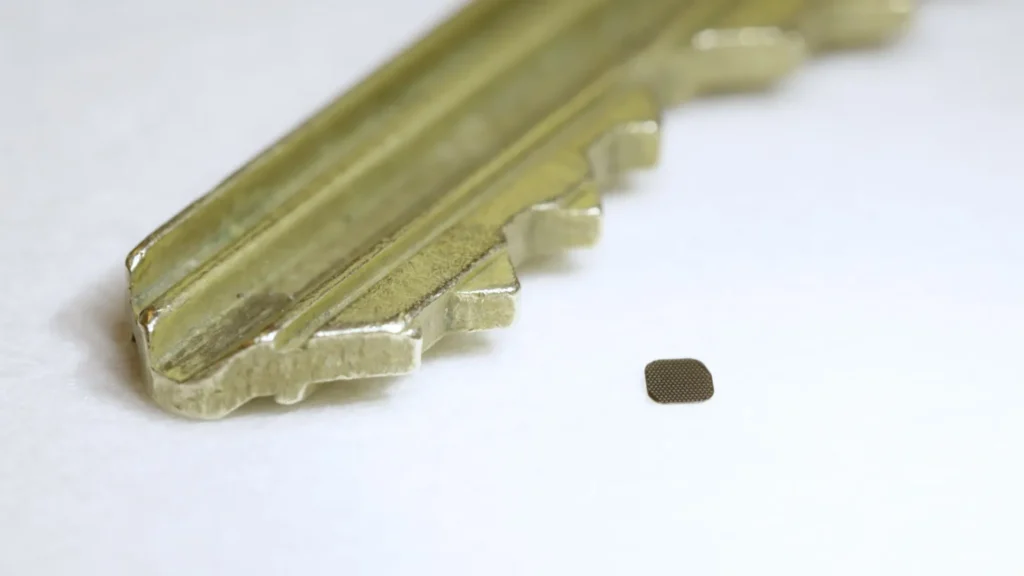Ogni giorno medici e terapisti lavorano per garantire la sicurezza dei loro pazienti. Le voci mediche, la disinformazione e una rete online di fonti poco affidabili non rendono il loro lavoro più facile.
Come può testimoniare chiunque abbia cercato su Google i propri sintomi e si sia convinto di avere un tumore al cervello, Internet rende molto facile (erroneamente) autodiagnosticare i propri problemi di salute. E sebbene i social media e altri forum digitali possano essere un’ancora di salvezza per alcune persone in cerca di una diagnosi o di una comunità, quando le informazioni sono errate, possono mettere in pericolo il loro benessere e persino la loro vita.
Purtroppo, questa tendenza moderna a “fare ricerche per conto proprio” è diventata ancora più pronunciata durante la pandemia di coronavirus.
Abbiamo chiesto a diversi professionisti sanitari in che modo questo cambiamento stia modificando la loro professione. Ci hanno detto che sono costretti ad adattare il modo in cui trattano i pazienti. Le esperienze sono molto diverse: alcuni dicono che i pazienti chiedono semplicemente maggiori informazioni su determinati trattamenti perché sono preoccupati della loro efficacia. Altri sentono dire dai loro pazienti che semplicemente non si fidano delle autorità. Altri ancora affermano che i pazienti rifiutano del tutto la medicina basata sull’evidenza a favore di teorie alternative che hanno trovato online.
Queste sono le loro storie, raccontate con le loro stesse parole.
Le interviste sono state modificate per motivi di lunghezza e chiarezza.
Il medico che cerca di stabilire obiettivi condivisi
David Scales
Medico internista ospedaliero e assistente professore di medicina,
Weill Cornell Medical College
New York City
Tutti i miei colleghi hanno storie da raccontare su pazienti che hanno rifiutato le cure o che avevano punti di vista molto particolari su come dovessero essere somministrate. A volte ciò è dovuto alla religione. Ma penso che ciò che è cambiato siano le persone, non necessariamente dal punto di vista religioso, che hanno convinzioni molto radicate che a volte, sulla base di tutte le prove che abbiamo, sono in contraddizione con i loro obiettivi di salute. E questa è una situazione molto difficile.
Una volta ho curato un paziente affetto da una malattia del tessuto connettivo chiamata sindrome di Ehlers-Danlos. Sebbene non ci siano dubbi sull’esistenza della malattia, ci sono molti dubbi e incertezze su quali sintomi possano essere attribuiti all e di Ehlers-Danlos. Ciò significa che può rientrare in quella che gli scienziati sociali chiamano una “malattia contestata”.
Le malattie contestate erano un tempo causa di movimenti discutibilmente marginali, ma sono diventate molto più importanti dall’ascesa dei social media a metà degli anni 2010. I pazienti spesso cercano informazioni che rispecchino la loro esperienza.
Questa paziente era molto titubante riguardo ai vari trattamenti ed era chiaro che stava ottenendo le sue informazioni da fonti, direi, sospette. Seguiva online persone che non erano necessariamente affidabili, quindi mi sono seduta con lei e le abbiamo cercate su Quackwatch, un sito che elenca miti e comportamenti scorretti in materia di salute.
“Era estremamente informata e aveva fatto molte ricerche per conto suo, ma aveva difficoltà a distinguere tra fonti attendibili e non attendibili”.
Era ancora disposta ad accettare il trattamento, era estremamente informata e aveva fatto molte ricerche per conto proprio, ma aveva difficoltà a distinguere tra fonti attendibili e non attendibili e aveva convinzioni radicate che enfatizzavano eccessivamente alcuni aspetti, come i sintomi che potevano essere attribuiti ad altre cause.
I medici hanno gli strumenti per lavorare con i pazienti che lottano con queste sfide. Il primo è il colloquio motivazionale, una tecnica di consulenza sviluppata per le persone con disturbi da uso di sostanze. Si tratta di un approccio non giudicante che utilizza domande aperte per far emergere le motivazioni delle persone e individuare dove c’è una discrepanza tra i loro comportamenti e le loro convinzioni. È molto efficace nel trattamento delle persone che sono riluttanti nei confronti dei vaccini.
Un altro è un approccio chiamato “processo decisionale condiviso”. Per prima cosa individuiamo gli obiettivi del paziente e poi cerchiamo un modo per allinearli con ciò che sappiamo essere il modo più efficace per trattarli. È qualcosa che utilizziamo anche per le cure di fine vita.
Ciò che mi preoccupa è che sembra esserci una dinamica per cui i pazienti arrivano con una convinzione fissa su come diagnosticare la loro malattia, su come dovrebbero essere trattati i loro sintomi e su come curarli in un modo completamente avulso dai tipi di medicina che si trovano nei libri di testo, e che la stessa dinamica sta iniziando a estendersi anche ad altre malattie.
Il terapeuta si impegna a essere presente quando la febbre da complottismo si abbassa
Damien Stewart
Psicologo
Varsavia, Polonia
Prima del Covid, nessun cliente aveva mai sollevato teorie cospirative durante le nostre sedute. Ma una volta iniziata la pandemia, queste teorie sono passate dall’essere divertenti o innocue a qualcosa di pericoloso.
Nella mia esperienza, i vaccini sono stati il primo argomento su cui ho iniziato a notare una certa militanza: persone che rischiavano di perdere il lavoro perché non volevano vaccinarsi. A un certo punto, un convinto sostenitore delle teorie del complotto mi ha detto: “Potrei anche indossare una stella gialla come gli ebrei durante l’Olocausto, perché non mi vaccinerò”.
Ho provato una rabbia pura e ho raggiunto un punto nel mio percorso terapeutico che non pensavo sarebbe mai arrivato: ho scoperto che c’era un limite che un cliente poteva superare e che io non potevo tollerare. Ho parlato in modo molto diretto, probabilmente insolito per lui, e ho contestato la sua teoria del complotto. Lui si è arrabbiato molto e ha riattaccato il telefono.
Questo mi ha fatto capire come avrei dovuto affrontare la situazione in futuro e mi ha spinto a sviluppare un approccio diverso: non contestare la teoria del complotto, ma discuterne con delicatezza, fornire punti di vista alternativi e porre domande. Cerco di trovare il valore terapeutico nelle informazioni e nelle conversazioni che abbiamo. La mia convinzione, e le prove sembrano dimostrarlo, è che le persone credono nelle teorie del complotto perché c’è qualcosa di sbagliato nella loro vita che è inspiegabile e hanno bisogno di qualcosa che spieghi loro cosa sta succedendo. E anche se non credo né condivido in alcun modo ciò che dicono, penso di dover stare qui e avere questa conversazione, perché un giorno questa persona potrebbe uscirne e io devo essere qui quando ciò accadrà.
Come psicologo, devi ricordare che queste persone che credono in queste cose sono estremamente vulnerabili. Quindi la mia rabbia nei confronti di queste teorie del complotto è cambiata: non è più diretta verso chi le diffonde, la persona seduta di fronte a me che dice queste cose, ma verso chi le alimenta.
Il medico del pronto soccorso che cerca di ricollegare i pazienti alle prove
Luis Aguilar Montalvan
Medico di pronto soccorso
Queens, New York
Il pronto soccorso è essenzialmente il polso di ciò che sta accadendo nella società. È questo che mi ha davvero attratto. E penso che il compito del medico di pronto soccorso, in particolare in un contesto di cambiamento delle opinioni politiche o della fiducia nella medicina occidentale, sia quello di cercare di ricollegarsi con le persone. Semplicemente creare l’esperienza necessaria per spingere qualcuno a riconsiderare il proprio rapporto con questa medicina basata sull’evidenza.
Quando lavoravo nel reparto di pronto soccorso pediatrico alcuni anni fa, abbiamo assistito a una recrudescenza di malattie che pensavamo di aver debellato, come il morbillo. Di solito lo spiegavo al caregiver del bambino dicendo: “Questa è una malattia per la quale di solito usiamo i vaccini, che possono prevenirla nella maggior parte delle persone”.
“Il medico ora è più simile a un consulente o a un fornitore di servizi al cliente che a un’autorità. … Il rapporto di potere è cambiato”.
Il sentimento dei miei pazienti adulti che sono riluttanti a vaccinarsi o ad assumere determinati farmaci sembra derivare da una sfiducia nei confronti del governo o del “sistema” piuttosto che da qualcosa che Robert F. Kennedy Jr. dice direttamente, per esempio. In questo periodo di , vedo sicuramente più pazienti che mi chiedono cosa possono assumere per gestire una condizione o un dolore che non sia un farmaco. Rispondo loro che le mie conoscenze si basano sulla scienza e spiego quali farmaci prescriverei normalmente ad altre persone nella loro situazione. Cerco di dare loro autonomia, reintroducendo l’idea di attenersi alle prove scientifiche, e nella maggior parte dei casi sono riconoscenti e cortesi.
Il ruolo del medico è cambiato negli ultimi anni: c’è stato un cambiamento culturale. A quanto mi risulta, un tempo il paziente faceva quello che diceva il medico. Alcuni medici rimproveravano i genitori che non avevano vaccinato i propri figli. Ora ci stiamo allontanando da questo approccio e il medico è più simile a un consulente o a un fornitore di servizi al cliente che a un’autorità. Penso che ciò possa essere dovuto al fatto che abbiamo visto molti cattivi attori in medicina, quindi i rapporti di potere sono cambiati.
Penso che se avessimo un approccio più unificato a livello nazionale, se avessimo un rapporto realmente unificato e trasparente con la popolazione, questo ci metterebbe sulla strada giusta. Ma non sono sicuro che lo abbiamo mai avuto.
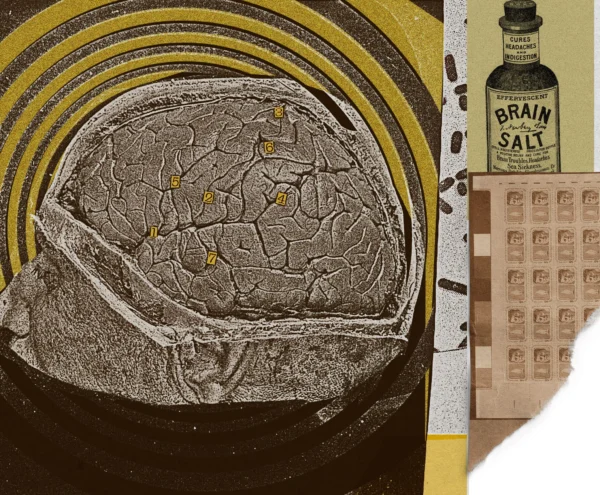
STEPHANIE ARNETT/MIT TECHNOLOGY REVIEW | PUBLIC DOMAIN
La psicologa che ha aiutato pazienti affetti da gravi malattie mentali durante la pandemia
Michelle Sallee
Psicologa, certificata in psicologia delle malattie mentali gravi
Oakland, California
Sono una psicologa clinica che lavora solo con persone che sono state ricoverate in ospedale almeno tre volte negli ultimi 12 mesi. Mi occupo sia di terapia individuale che di lavoro di gruppo e, diversi anni fa, durante la pandemia, ho scritto un programma di 10 settimane per i pazienti su come affrontare il confinamento, seguire le linee guida di sicurezza e le loro preoccupazioni sui vaccini.
I miei gruppi erano molto strutturati intorno alla pratica basata sull’evidenza e avevo delle regole per i gruppi. Per prima cosa, dicevo alle persone che l’obiettivo non era quello di convincerle a rinunciare alle loro teorie cospirative; il mio obiettivo non era quello di convincerle a vaccinarsi. Il mio obiettivo era quello di fornire loro un luogo sicuro dove poter parlare delle cose che li terrorizzavano. Volevamo ridurre l’ansia, la depressione, i pensieri suicidi e la necessità di ricoveri psichiatrici.
Metà del gruppo era favorevole ai requisiti di salute pubblica e la loro paranoia e paura per la sicurezza riguardava le persone che non si vaccinavano; l’altra metà era fortemente contraria al fatto che qualcuno diverso da loro decidesse che avevano bisogno di un vaccino o di una mascherina. Entrambe le parti temevano per la propria vita, ma l’una dell’altra.
Volevo assicurarmi che tutti si sentissero ascoltati, ed era davvero importante poter parlare di ciò in cui credevano, ad esempio alcune persone pensavano che il governo stesse cercando di rintracciarci e persino di ucciderci, senza essere giudicati dagli altri. La mia teoria è che se si permette alle persone di parlare liberamente di ciò che hanno in mente senza bloccarle con le proprie opinioni o giudizi, alla fine troveranno la loro strada. E molte volte funziona.
Le persone sono rimaste bloccate nella loro teoria del complotto o nella loro paranoia per molto tempo perché litigano sempre con gli altri al riguardo, tutti dicono loro che non è vero. Quindi abbiamo semplicemente discusso apertamente di queste cose.
“Le persone sono rimaste bloccate sulle loro teorie cospirative per molto tempo perché litigano sempre con gli altri su questo argomento, tutti dicono loro che non è vero”.
Ho condotto il programma quattro volte per un totale di 27 persone, e la cosa che ricordo di più è quanto tutti fossero rispettosi, tolleranti ed empatici, ma comunque onesti riguardo ai propri sentimenti e alle proprie opinioni. Alla fine del programma, la maggior parte dei partecipanti ha riferito una diminuzione dello stress legato alla pandemia. La metà ha riferito una diminuzione dello stress percepito in generale, mentre l’altra metà non ha riportato alcun cambiamento.
Direi che ora si parla molto meno di vaccini e che il Covid non è più un argomento ricorrente. Ma emergono altre malattie: i pazienti dicono: “Il mio medico mi ha detto che devo sottopormi a questo intervento, ma io so per chi lavorano”. Tutti hanno le loro preoccupazioni, ma quando una persona affetta da psicosi ha delle preoccupazioni, queste diventano deliranti, paranoiche e psicotiche.
Mi piacerebbe che un numero maggiore di operatori sanitari ricevesse una formazione più approfondita sulle malattie mentali gravi. Non si tratta solo di persone che hanno bisogno di andare in ospedale per essere sottoposte a una nuova terapia farmacologica per un paio di giorni. C’è tutta una vita che deve essere presa in considerazione, e loro se lo meritano. Mi piacerebbe vedere più contesti di gruppo che combinino psicoeducazione, ricerca basata sull’evidenza, formazione professionale e processo, perché la ricerca dice che è questa la combinazione davvero importante.
Nota dell’editore: Sallee lavora per un grande dipartimento di psichiatria HMO e il suo racconto qui non è a nome, né approvato da, né parla a nome di alcuna organizzazione più grande.
L’epidemiologa che sta ripensando come colmare le differenze tra cultura e comunità
John Wright
Medico e epidemiologo
Bradford, Regno Unito
Lavoro a Bradford, la quinta città più grande del Regno Unito. Ha una grande popolazione sudasiatica e alti livelli di povertà. Prima del Covid, direi che c’era una crescente consapevolezza delle cospirazioni. Ma durante la pandemia, penso che il lockdown, l’isolamento, la paura di questo virus sconosciuto e poi l’incertezza sul futuro si siano combinati in una tempesta perfetta per evidenziare l’attrazione latente delle persone verso ipotesi alternative e cospirazioni: era un terreno fertile. Sono medico del Servizio Sanitario Nazionale da quasi 40 anni e, fino a poco tempo fa, il Servizio Sanitario Nazionale godeva di ottima reputazione, di grande fiducia e di grande sostegno da parte dell’opinione pubblica. La pandemia è stata la prima occasione in cui ho iniziato a vedere erodersi tutto questo.
Non si trattava solo di teorie complottistiche sui vaccini o sui nuovi farmaci, ma anche di un indebolimento della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Ricordo una donna anziana che era arrivata al pronto soccorso con il Covid. Stava molto male, ma nonostante tutti i nostri sforzi non voleva essere ricoverata in ospedale, perché circolavano teorie complottistiche secondo cui stavamo uccidendo i pazienti in ospedale. Così è tornata a casa e non so cosa le sia successo.
L’altro grande cambiamento degli ultimi anni è stato rappresentato dai social media e dai social network, che hanno ovviamente amplificato e accelerato le teorie alternative e le cospirazioni. È stata la miccia che ha permesso a queste teorie cospirative di diffondersi a macchia d’olio. A Bradford, in particolare tra le comunità etniche minoritarie, si sono creati legami più forti tra loro, che hanno permesso una diffusione più rapida, ma anche una sfiducia più strutturale.
I tassi di vaccinazione sono diminuiti dall’inizio della pandemia e stiamo assistendo a un calo della diffusione dei vaccini contro la meningite e l’HPV nelle scuole tra le famiglie dell’Asia meridionale. In definitiva, questo richiede un approccio sociale più ampio rispetto alla semplice somministrazione di vaccini da parte dei singoli medici. Nel 2007 abbiamo avviato un progetto chiamato Born in Bradford che segue più di 13.000 famiglie, tra cui circa 20.000 adolescenti durante la loro crescita. Uno dei nostri principali obiettivi è capire come utilizzano i social media e in che modo questi influiscono sulla loro salute mentale, quindi chiediamo loro di donarci i loro media digitali in modo da poterli esaminare in tutta riservatezza. Speriamo che questo ci permetta di esplorare complotti e influenze.
La sfida per la prossima generazione di medici e clinici residenti è: come incoraggiare l’alfabetizzazione sanitaria nei giovani su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato senza essere paternalistici? Dobbiamo anche migliorare il nostro impegno con le persone come sostenitori della salute per contrastare alcune delle narrazioni online. Il sito web del Servizio Sanitario Nazionale non può competere con il contenuto coinvolgente di TikTok.
Il pediatra che si preoccupa della narrativa pubblica confusa sui vaccini
Jessica Weisz
Pediatra
Washington, DC
Sono una pediatra ambulatoriale, quindi mi occupo molto di cure preventive, controlli e visite mediche, e tratto tosse e raffreddori, cose di questo tipo. Ho seguito una formazione specifica su come supportare le famiglie nel processo decisionale clinico relativo ai vaccini, e ogni famiglia vuole il meglio per il proprio figlio, quindi supportarle fa parte del mio lavoro.
Non vedo espressioni specifiche di teorie cospirative, ma penso che ci siano più domande sui vaccini nelle conversazioni che in genere non ho mai dovuto affrontare prima. Ho scoperto che i genitori e gli assistenti sanitari fanno domande generali sui rischi e sui benefici dei vaccini. Noi cerchiamo semplicemente di ribadire che i vaccini sono stati studiati, che sono programmati appositamente per proteggere un sistema immunitario immaturo quando è più vulnerabile e che vogliamo che tutti siano al sicuro, in buona salute e forti. È così che possiamo fornire protezione.
“Penso che ciò che crea confusione sia il fatto che i titoli dei giornali seminano allarme, mentre la maggior parte dei pazienti, delle famiglie e degli assistenti sono motivati e vogliono vaccinarsi”.
Ritengo che il discorso pubblico sia ingiustamente fonte di confusione per le famiglie, quando oltre il 90% di esse desidera ancora che i propri figli siano vaccinati. Le famiglie che non sono così interessate o che hanno domande in merito richiedono in genere più colloqui per essere supportate nel loro processo decisionale. È molto raro che basti un solo colloquio.
Penso che ciò che crea confusione sia il fatto che i titoli dei giornali seminano allarme, mentre la maggior parte dei pazienti, delle famiglie e degli operatori sanitari sono motivati e desiderano vaccinarsi. Ad esempio, alcuni titoli sui recenti cambiamenti apportati dal CDC fanno sembrare che si tratti di un enorme cambiamento clinico, mentre in realtà non è un cambiamento così grande rispetto a ciò che si fa normalmente. Nella mia pratica clinica standard, non somministriamo il vaccino combinato MMRV ai bambini di età inferiore ai quattro anni, e questa è stata la prassi standard in tutti i luoghi in cui ho lavorato sulla costa orientale. [Nota dell’editore: all’inizio di ottobre, il CDC ha aggiornato la sua raccomandazione secondo cui i bambini piccoli devono ricevere il vaccino contro la varicella separatamente dal vaccino combinato contro morbillo, parotite e rosolia. Molti medici, tra cui Weisz, offrono già le vaccinazioni separatamente].
Se si guardano i sondaggi pubblici, i pediatri sono ancora i più affidabili [tra gli operatori sanitari] e io vivo in una giurisdizione con una politica piuttosto rigida in materia di vaccinazioni scolastiche. Penso che le persone ricevano informazioni da più fonti, ma alla fine, sia in termini di tassi nazionali che di ciò che vedo nella pratica clinica, stiamo davvero assistendo al fatto che la maggior parte delle famiglie desidera i vaccini.